“Il settanta per cento del mio corpo è composto da film”. Questa frase è uno degli aforismi più noti di Hideo Kojima, il visionario game designer a cui dobbiamo uno dei più recenti candidati a gioco dell’anno, Death Stranding. Il nostro Davide lo ha recensito sperticando per esso le più svariate lodi, ma non è sul suo valore artistico che vorremmo soffermarci oggi. Cioè, in realtà sì, ma c’è dell’altro.
L’enfasi sulla trama e sulle cutscene che Kojima ha sempre riversato in ogni sua opera, oltre a valere a Death Stranding la fama di un gioco dove “nelle prime due ore e mezza si tocca il controller per cinque minuti”, ci porta a considerare la linea di confine tra film e videogioco. Un concetto da sempre chiaramente tangibile, questo, che ultimamente si sta facendo via via più labile, sfocato, quasi sibillino. A metà strada tra una distinzione e un legame indissolubile.

Non è la prima occasione in cui i due mondi si toccano come se fossero i polpastrelli di Dio e di Adamo nella Creazione di Michelangelo: è frutto di un tango lento, graduale, sensuale, pieno di seduzione reciproca tra la settima arte e uno dei medium più giovani, che vanta il cinema tra le sue muse. Come siamo arrivati in un mondo dove fa più discutere un gioco dove l’interazione quasi viene meno rispetto a un suo compare portato su grande schermo? Cerchiamo di sbrogliare la matassa.
Tutto iniziò con gli yankee
La citazione di Hideo Kojima nasce dalla sua natura di grande estimatore della cultura occidentale. Non che questo sia una rarità nella terra del Sol Levante, anzi. Però Kojima è quasi una sorta di indice di gradimento vivente per quanto concerne ogni materiale mediatico nato in America. Non dovrebbe stupire nessuno, dunque, che il profilo Twitter di Kojima contiene un numero di tweet in lingua autoctona tanto ridotto da poter venire contato sulle dita di una mano.
Se quello di cultura è un concetto paragonabile a un organismo, l’arte ne costituisce l’anima, l’apparato circolatorio, il sistema nervoso. La conoscenza premia gli audaci che mirano a perseguirla, facendosi spingere dalle sue ali, sin dagli albori del genere umano. Eppure le differenze culturali sono così onnipresenti da rendere inconciliabili gli episodi dei Simpson da quelli di Dragon Ball Z con i quali i primi condividono la fascia oraria del primo pomeriggio di Italia 1.

I videogiochi non rappresentano certo un’eccezione nell’incontro tra culture. Capcom, dopo aver creato il robottino Mega Man ispirandosi allo stesso Astro Boy di cui non riuscì ad avere i diritti, per conto di Disney creò il videogioco ufficiale di Duck Tales, tuttora considerato uno dei migliori titoli su licenza, basandosi proprio sullo stile di Mega Man. Insomma, il mondo è diventato veramente piccolo in tempi non sospetti, prima ancora che Hideo Kojima avesse modo di dimostrarsi meritevole di una cittadinanza statunitense onoraria.
Ma mentre (un uso poetico e metaforico dell’avverbio) Ninja Gaiden su Nintendo Entertainment System sperimentava con i tempi narrativi tipici del cinema, intrisi di pause e di ritmi lenti, pacati, quasi solenni, ecco che il cinema partoriva il film su licenza di Super Mario Bros., tristemente figlio di un’epoca in cui prima si spendevano milioni per avere i diritti di un’opera da trasporre su grande schermo, per poi tagliare tutto ciò che “in un film non funziona”. Il risultato fu disastroso, tant’è che – anime di Pokémon permettendo – Nintendo stroncò la sua relazione abusiva con il cinema.
“Pronto… ci vediamo per un caffè? Mi manchi ancora…”
Dopo aver ricalcato le copertine dei film nelle icone dei personaggi dei primi giochi della serie Metal Gear, Hideo Kojima sfoggiò quanto appreso dalla sua passione cinefila nel debutto su PlayStation con il primo episodio della saga a vantare il sottotitolo “Solid”. Il risultato nei primi minuti di Metal Gear Solid è già visibile agli occhi di tutti: i nostri televisori a tubo catodico, definizione standard e cavi SCART si sono dimostrati capaci di sostituire la palese natura rudimentale dei modelli 3D dell’epoca con la sensazione viscerale di avere davanti i personaggi di un film, tra un “titolo di testa” di pregevole e cinematografica fattura e l’altro.
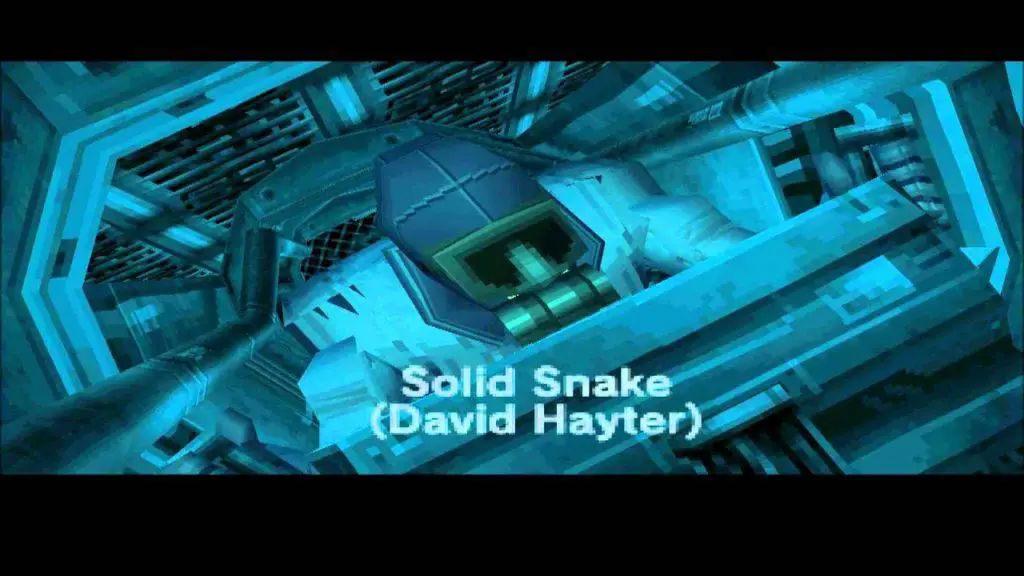
Ad unirsi all’amore per il fotorealismo, talvolta a discapito del gameplay, è stata l’industria videoludica occidentale. Esperimenti di motion capture come L.A. Noire di Rockstar ci hanno mostrato quanto vivo e pulsante possa essere un mondo nato per essere, ironicamente, governato dalle nostre dita, mentre la saga Assassin’s Creed si è dimostrata capace di fare il salto sul grande schermo praticamente senza problemi, predisposta ad azione e narrazione in egual misura così com’è. Come vanno le cose, invece, sul fronte del cinema stesso?
Dall’eterno sconforto a una vita niente male
Ogni attore è “geneticamente nato” per un determinato ruolo. Nel caso dell’attore comico Steve Carell, è stato il caso dell’agente Maxwell Smart in Agente Smart – Casino Totale, mentre per Angelina Jolie è stata l’archeologa più prosperosa del mondo, l’inglesissima Lara Croft della serie Tomb Raider. Nonostante questa predisposizione naturale a una determinata maschera, però, anche il film omonimo (con Culla della Vita annessa) cadde nelle stesse trappole di ogni lungometraggio basato su un videogioco: un chiaro segno che non ogni opera è nata per diventare un film.
Non è che per forza ogni tentativo di trasporre un videogioco su grande schermo deve tradursi sempre in un disastro, però. La saga cinematografica di Resident Evil, sebbene non sia il nuovo Quarto Potere, ha saputo accaparrarsi l’affetto dei fan degli omonimi videogiochi, grazie anche all’interpretazione di Milla Jovovich con la quale l’attrice ha trasmesso al pubblico l’adrenalinico mix tra azione e suspence tipico della serie horror di Capcom.

Gli esempi più lusinghieri, però, non bastano ancora a proiettare un’ombra abbastanza grande nei confronti della stragrande maggioranza di questi tentativi. Al di fuori delle disgraziate trasposizioni cinematografiche firmate dal pugile/regista (in quest’ordine) tedesco Uwe Boll, non c’è stato praticamente alcun adattamento per il grande schermo di un solo videogioco in grado di controbattere all’opinione della critica blasonata della settima arte, primo fra tutti Roger Ebert.
Questo compianto critico del cinema, tristemente venuto a mancare di recente, è sempre stato difficile da convincere. Al di fuori di pochissime eccezioni, infatti, Ebert ha sempre favorito il cinema più ricercato, tendendo ad una classica predilezione per il drammatico. La sua recensione del film di Doom si è conclusa con la frase: “Il film è stato ‘ispirato’ dal famoso videogioco. No, non l’ho mai giocato né mai lo farò, ma so come ci si sente a non giocarlo, perché ho visto il film. [Vedere] Doom è come se arrivasse un ragazzino a casa mia e si appropriasse del mio computer senza farmi giocare”. Ma che intendeva con “mai lo farò”?

Una delle ultime azioni di Ebert mentre era in vita è stata quella di punzecchiare l’alveare che è la community dei videogiochi, asserendo apertamente che non siano una forma d’arte. Dopo un relativo polverone, se così vogliamo definirlo, ha smentito la sua precedente dichiarazione riconoscendo i meriti artistici di questo giovane medium, citando Shadow Of The Colossus tra i suoi esempi. Ed è intorno a questo periodo che la situazione del cinema videoludico ha iniziato a cambiare in meglio.
Il titolo di questa sezione allude al fumetto indie Scott Pilgrim, il cui adattamento Scott Pilgrim VS. The World è stato eletto all’unanimità il miglior tentativo di creare un “gaming movie” nell’anno della sua uscita, il 2010. Mentre questo (divertentissimo) film è nato da un fumetto, oltre ad essere straordinariamente fedele nella trama e nei toni al materiale originale (una rarità per Hollywood, purtroppo) si basa su un’opera di suo governata dalla logica dei videogiochi. Nel mondo di Scott Pilgrim si esplode in un mare di monete quando si viene uccisi, si sale di livello, e le citazioni a The Legend Of Zelda fioccano a piè sospinto.

Al di là degli incassi, Scott Pilgrim VS. The World ha dimostrato che mostrare una barra della vita e un contatore delle combo in una scena d’azione non lede in alcun modo al godimento che si può trarre da una pellicola. Il successo di questo film, forse, è ciò che ha contribuito a dare una spintarella a Disney, che aveva lasciato nella sua metaforica soffitta quel dimenticato Joe Jump troppo, troppo a lungo. Due anni dopo, avremmo avuto Ralph Spaccatutto.
Il film che ho citato in Nintendo Unplugged non si basa in alcun modo su un videogioco nello specifico, ma il cinquantaduesimo classico Disney fa proprio di questo il suo punto di forza. Ralph Spaccatutto, in lavorazione dagli anni ottanta sotto il nome di High Score (e accantonato con il nome di Joe Jump prima di risorgere), è una lettera d’amore ai videogiochi in toto e, con essi, all’immaginazione che hanno saputo ispirare nel cuore di milioni di giocatori in tutto il globo. L’aggancio narrativo è quello delle sale giochi, per renderne appetibile la premessa anche al pubblico più avanti con gli anni, ma nonostante ciò la pletora di citazioni e di cameo (con una richiesta di diritti necessaria a rendere Ralph e il suo “gioco” credibile come videogioco realmente esistente) ha portato una miriade di appassionati nelle sale.

Il risultato, grazie anche a una sceneggiatura sagace curata da Rich Moore (I Simpson, Futurama, Drawn Together), è stato uno dei pochissimi classici Disney capaci di accaparrarsi un sequel al cinema, conquistandosi un affetto da parte sia dei videogiocatori che dagli appassionati dell’animazione stessa. Con questo, però, non possiamo nemmeno dire che i primi passi in avanti svolti dal cinema nei confronti dell’intrattenimento interattivo siano sufficienti a dormire sugli allori.
Ce l’ha purtroppo dimostrato Pixels, bizzarro ibrido tra trasposizione videoludica e disaster movie, tratto dall’omonimo cortometraggio e impreziosito, in via teorica, dall’aggiunta di Adam Sandler. Suo malgrado, a discapito della spettacolarità data da un uso sapiente dei voxel tra gli effetti speciali, il risultato è pur sempre un film di Adam Sandler: l’umorismo spesso grezzo dell’attore protagonista, nonostante il talento di comprimari quali Peter Dinklage e Josh Gad (soprattutto il primo dei due), trascina a fondo una pellicola altrimenti apprezzabile già per il suo sfrenato citazionismo.

Il caso è chiuso?
Dopo i passi in avanti compiuti da Scott Pilgrim Vs. The World e Ralph Spaccatutto, con l’uscita di Pixels sembrava che il cinema videoludico fosse destinato a rimanere un sottogenere stagnante dedicato solo a una nicchia di ristrettissimi appassionati, con l’occasionale spettatore “di lì per caso”. Il problema di questa situazione di stallo è che nessuno beneficia davvero dei compromessi: la critica che ama la settima arte giudicandone le opere secondo i parametri cinematografici odia i film sui videogiochi, mentre i “compromessi necessari” apportati dai produttori esecutivi non solo non bastano ad ammaliare i cinefili, ma finiscono anche per allontanare gli appassionati del materiale originale.
A peggiorare le cose, il seguito di Ralph Spaccatutto ha deciso di spostare il focus dai videogiochi (comunque presenti nella pellicola) alla sfera del web, comunicando indirettamente e involontariamente all’industria dell’intrattenimento un messaggio chiaro: non c’è posto nel cinema per i film videoludici intesi come genere o come saghe. Disney, d’altronde, è un punto di riferimento per l’intrattenimento, e dedicare ad internet il palcoscenico del seguito di un’opera nata come lettera d’amore ai videogiochi non è incoraggiante per chi lo ha atteso per sei anni (anche se vedere Sonic leggere Dostoevskij con un paio di occhiali da vista vale da solo il prezzo del biglietto).

Ready Player One, sebbene curato da qualcuno di relativamente lontano dall’immagine del videogiocatore quanto solo Steven Spielberg può esserlo, ha saputo giostrare un elevato numero di cenni alla cultura popolare sia all’interno del mondo videoludico che fuori. Proprio per questo, però, l’adattamento del romanzo di Ernest Cline conta relativamente come esempio di “film di videogiochi”: includere avatar estranei al gaming, oltre ad essere un’ulteriore dimostrazione della già citata discriminazione verso i videogiochi, è un po’ come “barare”.
E poi è arrivato lui. Puntando sul live-action anziché sull’animazione e proponendo versioni iperrealistiche di creature che non sono nate per esserlo, il film di cui stiamo per parlare si è basato su uno spinoff anziché sulla serie principale di videogiochi a cui faceva riferimento. Trattasi di Pokémon: Detective Pikachu, nelle cui premesse i fan più fatalisti sono stati inizialmente molto rapidi a vedere un disastro annunciato.

Contro ogni pronostico, invece, il film è stato accolto da un autentico plebiscito. Il design dei Pokémon ha trovato il giusto equilibrio tra realismo e riconoscibilità, mentre il carisma di Ryan Reynolds ha plasmato la versione live-action di Pikachu quanto basta da darle un’inconfondibile identità ben diversa da qualsiasi altra incarnazione del personaggio. Un rispetto quasi reverenziale nei confronti dei fan (filtrato da un fanservice dosato in modo saggio e ragionato) ha infine elevato la pellicola al nuovo standard per ogni adattamento cinematografico di un videogioco negli anni a venire.
Certo, Hollywood cerca sempre di mettere lo zampino dei produttori per quanto riguarda il “sappiamo meglio di voi ciò che volete”: ce ne ha dato prova Sonic: Il Film, il cui trailer iniziale ha suscitato una tale ondata di sdegno da parte dei fan da costringere il regista a posticipare l’intera pellicola fino al prossimo San Valentino per riportare il look di Sonic a un compromesso accettabile dagli appassionati. L’industria cinematografica non è mai stata completamente incapace di cospargersi il capo di cenere, ma un tale inginocchiamento sui ceci non ha davvero precedenti. Jim Carrey, che nel film interpreterà una versione del Dr. Eggman perfettamente fedele alla sua megalomania vista nei giochi, ha dichiarato in modo relativamente passivo-aggressivo che “si sta mettendo tutto nelle mani del pubblico”.

E i videogiochi che fanno?
Hollywood sta dunque iniziando gradualmente a capire i gusti dei videogiocatori, con una Nintendo abbastanza fiduciosa da affidarsi a Universal per un film d’animazione su Mario, ma i videogiochi non sono certo da meno. L’enfasi sulla narrazione inizialmente plasmata da Shigeru Miyamoto con il primo Donkey Kong si è evoluta quanto basta da competere con il cinema stesso per quanto riguarda la pura qualità.
I personaggi non sono solo espressivi: siamo arrivati, ad esempio, a Kingdom Hearts III che può vantare un Woody al pari di quanto visto in Toy Story e una versione di “Let it go” capace di migliorare quanto visto in Frozen, giusto per citarne uno. I giochi su licenza, quelli derivati da un film, hanno quasi completamente abbandonato la carenza di impegno che li contraddistingueva, diventando godibili senza alcuna punta di ironia.

Tornando allo stesso Death Stranding con cui abbiamo aperto questo lungo approfondimento, quest’evoluzione ci ha condotto a un’esperienza che potrebbe riportare i nomi degli attori in cima alla copertina, come se fosse la locandina di un film. Hideo Kojima, da estimatore della nostra cultura cinematografica qual è, ha dimostrato di comprenderla forse meglio di quanto non lo facciano molti esponenti della stessa, e come lui anche molti altri ambiziosi sviluppatori non mancano mai di riempire di prestigio il genere dal quale il nostro stesso iCrewPlay, così come altri siti, trae le sue stesse fondamenta.
Il fatto che i videogiochi abbiano fatto da apripista a un sito che ora tratta anche di cinema è emblematico del rispetto che, in fondo, la nostra cultura merita da sempre. La conoscenza è tentacolare, perché un concetto, un’idea, non può che condurre inevitabilmente ad altre, e altre ancora. Dai videogiochi si traggono libri, dai libri si traggono videogiochi, dai videogiochi si traggono film, dai film nascono libri, dai fumetti nascono videogiochi e così via.
La cultura non va denigrata, né ostacolata, né tantomeno rifuggita. Semmai, va accolta a braccia aperte: a discapito di ogni ignoranza e pregiudizio, e tradotta in altre forme senza di essi, aprendola a un nuovo pubblico capace di gustarla secondo i propri canoni. L’ignoranza che avvelena il mondo, d’altronde, si combatte anche così.